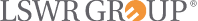Il servizio di trasporto urbano di Uber è, senza alcun dubbio, una sorprendente realtà per chi lo sperimenta per la prima volta e a New York City in particolare. Gli Yellow Cabs sono un simbolo della città e catturano la nostra fantasia, ma in realtà sono mezzi quantomai scomodi: lo spazio per i passeggeri viene sacrificato per consentire al conducente di stare per 10 ore al volante un po’ più comodo, i sedili e gli ammortizzatori sono usurati, i prezzi sono alti perché regolati dall’amministrazione municipale che ha concesso solo 13000 medallions (licenze). Un tal numero di vetture si rivela del tutto insufficiente nelle ore di punta della metropoli o quando piove. In più gli Yellow Cabs si concentrano a Manhattan trascurando gli altri quartieri meno redditizi.
Questo razionamento ha portato il prezzo di una licenza vicino a 1 milione di dollari. Ne consegue che quasi nessuno riesce ad acquistarla singolarmente e ad avviare un’attività individuale. Le licenze e i taxi appartengono, infatti, a compagnie che assumono autisti stipendiati con bassi salari, per cui la mancia diventa un obbligo da parte dei passeggeri.
Uber e i suoi fratelli
New York è diventata però una specie di paradiso per gli utenti dei trasporti urbani, in quanto accanto agli Yellow Cabs, sono comparsi i Green Cabs e, oltre ad Uber, i suoi imitatori-concorrenti Lyft, Gett, Juno, Via. Tutto ciò è il frutto di una convergenza di tecnologie che hanno contribuito a far emergere il libero mercato nella sua forma più pura. Chi ha un’auto adeguata e la licenza per trasportare altre persone può diventare tassista part-time o a tempo pieno. Per questa ragione Uber prefigura un futuro che inevitabilmente toccherà, tra mille resistenze, anche il nostro paese, anche altri settori tra cui il retail. Grandi compagnie come Wal-Mart stanno già sperimentando la possibilità di utilizzare Uber e i suoi simili per la consegna a domicilio degli acquisti online. Instacart si muove nella stessa direzione.
Lasciare la libertà di operare alle leggi di mercato ha prodotto di conseguenza un grande miglioramento della qualità del servizio, una diminuzione del prezzo assieme alla creazione di molti nuovi posti e occasioni di lavoro. Collateralmente, ha permesso agli economisti di osservare per la prima volta delle vere, reali curve di domanda e di offerta. Esse erano state in precedenza delle astrazioni, teorizzate dai modelli euristici insegnati nelle università. Uber le ha materializzate con il proprio sistema. Utilizzando un flusso permanente di informazioni grazie al web e alimentando algoritmi che calcolano il prezzo del trasporto: a) in base alle richieste di un vasto pubblico di utenti e b) in base all’offerta di auto del suo network che si dichiarano in ogni momento liberamente disponibili, Uber riesce a far incontrare domanda e offerta al miglior prezzo per entrambi.
I vantaggi per il consumatore
Ovviamente con l’aumentare del numero di coloro che accettano di trasportare altre persone il prezzo di mercato tende a diminuire. Allo stesso tempo però la domanda degli utenti aumenta, a scapito dell’uso dell’auto privata. In breve il web sta distruggendo il monopolio potentissimo dei taxisti ufficialmente riconosciuti. Il web permette di raccogliere, inoltre, con precisione anche il grado di soddisfazione degli utenti per il servizio reso da ogni autista, consentendo così al sistema di gestire incentivi e disincentivi, migliorando lo standard complessivo di questa attività.
Dunque, se c’è maltempo, se ci sono eventi particolari con relativi afflussi di potenziali clienti, se il servizio è notturno, allora il prezzo richiesto aumenta e, viceversa, quando la domanda si indebolisce per la concorrenza o per altre specifiche circostanze, il prezzo viene ridotto.
Un altro rilevante risultato è, quindi, la creazione di un ingente surplus per il consumatore. Fissando il prezzo in base al livello della domanda e dell’offerta lo si rende, infatti, sistematicamente inferiore a quello che un cliente avrebbe dovuto pagare con una tariffa prefissata. Basti pensare che gli utenti di Uber nelle quattro città: Chicago, San Francisco, Los Angeles, e New York, in un anno superano i 100 milioni. Prezzi notevolmente inferiori a quelli amministrati significano dunque reddito disponibile che viene speso in altri beni e servizi.
Se a tutto ciò si aggiungono i concorrenti di Uber che da NYC cercano di espandersi negli USA e nel mondo, abbiamo un’idea di quale guadagno di produttività si prospetti per i sistemi di trasporto urbani dei paesi che, al contrario del nostro, si aprono alla logica del libero mercato. A questo bisogna aggiungere l’indubbio miglioramento qualitativo. Le auto dei micro-imprenditori del network sono più nuove, pulite e spaziose dei taxi gialli. Gli autisti sono tutti dotati di GPS, con cui minimizzano anche i percorsi più lunghi e complessi nel Bronx o a Brooklyn. Inoltre offrono bevande dissetanti e snack ai clienti e le mance non sono previste.
Uber non è esente da critiche, poiché esige una royalty su ogni transazione, lasciando ai tassisti oneri e rischi. Tuttavia il libero mercato corregge anche queste presunte storture. Infatti, ogni autista newyorkese da libero imprenditore, oggi utilizza più telefoni per servire in alternativa Uber, Juno, Via o Lefty a seconda del tragitto più vantaggioso che viene loro offerto e delle minori royalties pretese dalla centrale di coordinamento. Certo, qualcuno dice che guidando il taxi giallo guadagnava lo stesso reddito lavorando meno, con meno rischio, ma ciò che conta sempre ed inevitabilmente è la soddisfazione del cliente che – è bene ricordarlo – è egoista, spietato, irriconoscente di fronte ad alternative più convenienti.
Il caso dei network dei trasporti, pertanto, non va visto isolatamente, ma inquadrato come una tendenza che anticipa il futuro di molti altri settori in primo luogo dei servizi, ma in secondo luogo anche del commercio dei beni materiali e, insomma, anche del retail.
Di Amagi (Tirelli associati)