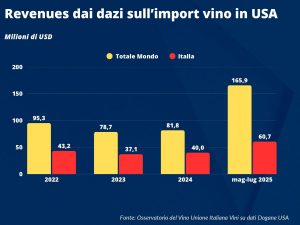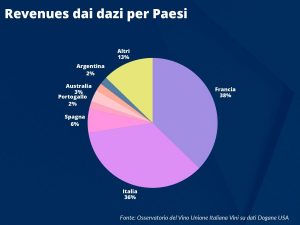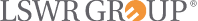Due edizioni limitate sviluppate esclusivamente per il mercato britannico e destinate a Morrisons, una delle principali insegne della Gdo inglese. Il Raviolificio Scoiattolo dà prova della sua capacità di interpretare le esigenze dei mercati esteri e di tradurle in soluzioni su misura per la grande distribuzione con un’abbinata davvero particolare. Le due referenze sono pensate per celebrare prima San Valentino e poi la Festa della Mamma e Pasqua: per questo saranno in promozione nel mese di febbraio e fino ai primi di aprile in circa 280 punti vendita nel Regno Unito.
UN RAVIOLO A FORMA DI CUORE, CON RIPIENO BRITISH
 Il primo prodotto, disponibile fino al 9 marzo, è un raviolo a forma di cuore, che nasce da uno stampo studiato ad hoc per ottenere un formato di circa 16 grammi, con una parte centrale ampia capace di contenere fino al 50% di ripieno, valorizzandone gusto e texture.
Il primo prodotto, disponibile fino al 9 marzo, è un raviolo a forma di cuore, che nasce da uno stampo studiato ad hoc per ottenere un formato di circa 16 grammi, con una parte centrale ampia capace di contenere fino al 50% di ripieno, valorizzandone gusto e texture.
Il ripieno, di ispirazione tipicamente anglosassone, è a base di guancia di bovino cotta a lungo in brasiera con alloro fresco, misto soffritto e vino rosso. La carne viene cotta intera, senza essere macinata, per preservarne la naturale fibrosità, che rimane visibile all’apertura del raviolo. Il colore scuro del ripieno, punteggiato dalla verdura del soffritto, e il profumo intenso richiamano immediatamente una carne a lunga cottura, come vuole la tradizione gastronomica d’oltremanica. Un prodotto gourmet, pensato per il banco gastronomia, proposto a un prezzo promozionale di 2,50 sterline.
Accanto alla referenza salata, Scoiattolo ha sviluppato una seconda proposta dolce, disponibile dal 2 marzo fino al 6 aprile, che gioca sulla novità del ripieno: un classico formato come il Gran Panzerotto, ma con un cuore di cioccolato fondente. L’idea nasce dal desiderio di sviluppare un raviolo dal profilo dolce, il cui ripieno fosse capace di richiamare l’esperienza del soufflé, con un cuore cremoso, in grado di sciogliersi in fase di cottura, offrendo una diversa interpretazione della pasta fresca ripiena. Una proposta distintiva e ancora poco esplorata nella categoria, pensata per rispondere alle aspettative del mercato di riferimento.
DAL CONTINUATIVO AI PRODOTTI PER INCURIOSIRE I CONSUMATORI
“Siamo entrati in Morrisons ad ottobre 2025 – racconta Alessandro Pedretti, Key Account Director di Scoiattolo – dopo molti mesi di lavoro, con diverse referenze a marchio Scoiattolo in continuativo su tutto l’anno, proposte adeguate al mercato e con un posizionamento mirato. Questo è stato possibile grazie alla fiducia dei buyer e dei category manager dell’insegna, che hanno visto in noi il partner ideale per arricchire con prodotti qualitativi e made in Italy il loro deli counter. Questo ci ha permesso di aumentare la presenza del nostro brand in UK, già da tempo sugli scaffali di Costco. Insieme abbiamo poi studiato due referenze preziose, golose e distintive, in edizione limited per un breve periodo e legate a ricorrenze ben precise, in grado di incuriosire i consumatori e di variare l’offerta a banco”.
 L’EXPORT INCIDE PER IL 70%
L’EXPORT INCIDE PER IL 70%
Le due limited edition rappresentano un esempio concreto della capacità di Scoiattolo di innovare formato, ricetta e processo produttivo per rispondere alle esigenze della grande distribuzione internazionale. Un approccio che ha permesso all’azienda di consolidare la propria presenza all’estero e di sviluppare progetti su misura per mercati con gusti, abitudini di consumo e occasioni d’acquisto differenti.
Oggi l’export rappresenta circa il 70% del fatturato di Scoiattolo, a conferma di una strategia fortemente orientata ai mercati internazionali. La crescita è trainata in particolare da USA e Canada, dove il brand è presente dal 2019, e dall’ingresso più recente, nel 2023, nei mercati asiatici e neozelandesi. Parallelamente, Scoiattolo collabora da molti anni con alcuni dei principali marchi della grande distribuzione in Olanda, Francia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Spagna e Germania.
 IL TAILOR MADE PAGA, ANCHE A VOLUME
IL TAILOR MADE PAGA, ANCHE A VOLUME
I volumi destinati all’estero sono cresciuti in modo significativo, passando dai 11,3 milioni di kg del 2022 ai 14,2 milioni di kg del 2024, per un valore complessivo di oltre 48 milioni di euro. Un risultato costruito nel tempo e dovuto – secondo l’azienda – a una forte capacità di ricerca e sviluppo, a un approccio tailor made e a un ricco assortimento che conta oggi oltre 250 ricette, 30 formati e 50 referenze complessive a marchio Scoiattolo commercializzate nel mondo.







 Inevitabili le ripercussioni, anche perché secondo Costantini sulla pasta i margini sono già bassi: “Vendite bloccate, ma soprattutto ingenti volumi di merce da immettere su mercato interno e su quello europeo con conseguente impatto sui prezzi. Lavoriamo in un mercato già di per sé saturo, che segue un trend costante e rassicurante, ma lento nei suoi movimenti. È difficile ripensare a dei repentini cambi di strategia per affrontare la nuova situazione ed ecco perché riteniamo sia urgente aprire un tavolo di lavoro comune con la Farnesina e con le associazioni di categoria in modo da adottare un approccio comune e far sentire un’unica voce”.
Inevitabili le ripercussioni, anche perché secondo Costantini sulla pasta i margini sono già bassi: “Vendite bloccate, ma soprattutto ingenti volumi di merce da immettere su mercato interno e su quello europeo con conseguente impatto sui prezzi. Lavoriamo in un mercato già di per sé saturo, che segue un trend costante e rassicurante, ma lento nei suoi movimenti. È difficile ripensare a dei repentini cambi di strategia per affrontare la nuova situazione ed ecco perché riteniamo sia urgente aprire un tavolo di lavoro comune con la Farnesina e con le associazioni di categoria in modo da adottare un approccio comune e far sentire un’unica voce”.
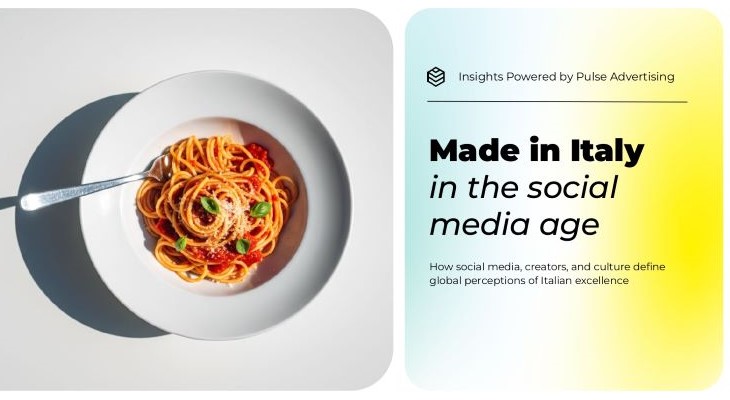
 “I dati mostrano una leadership inequivocabile in tutti i mercati analizzati – dichiara Paola Nannelli, Chief Sales Officer di Pulse Advertising (nella foto a sinistra) –. Anche nei mercati dove i media tradizionali restano forti, i social media occupano stabilmente la posizione n.1. Non è una tendenza: è la nuova realtà alla base del comportamento dei consumatori quando cercano prodotti Made in Italy”.
“I dati mostrano una leadership inequivocabile in tutti i mercati analizzati – dichiara Paola Nannelli, Chief Sales Officer di Pulse Advertising (nella foto a sinistra) –. Anche nei mercati dove i media tradizionali restano forti, i social media occupano stabilmente la posizione n.1. Non è una tendenza: è la nuova realtà alla base del comportamento dei consumatori quando cercano prodotti Made in Italy”. Il terzo punto riguarda i consumatori di domani: è necessario dare priorità a TikTok e Instagram per intercettare i futuri acquirenti del lusso; adeguare i budget ai pattern di utilizzo quotidiano dei diversi social, con l’obiettivo di costruire strategie social-first, aggiudicandosi un vantaggio strategico sui concorrenti che restano legati ai canali tradizionali. La quarta e ultima azione suggerita consiste nel focalizzare le campagne premium sui mercati con alta discovery social, valorizzando il concetto di Made in Italy.
Il terzo punto riguarda i consumatori di domani: è necessario dare priorità a TikTok e Instagram per intercettare i futuri acquirenti del lusso; adeguare i budget ai pattern di utilizzo quotidiano dei diversi social, con l’obiettivo di costruire strategie social-first, aggiudicandosi un vantaggio strategico sui concorrenti che restano legati ai canali tradizionali. La quarta e ultima azione suggerita consiste nel focalizzare le campagne premium sui mercati con alta discovery social, valorizzando il concetto di Made in Italy.